Di seguito il testo dell’intervento del nostro parroco, nell’incontro che si è tenuto oggi, alla presentazione del progetto “Per abitare Mirafiori”
“Cosa dire del nostro quartiere?
La situazione del nostro quartiere è arcinota perché la sua storia passata e recente è legata alla fabbrica, alla “mamma” FIAT. Quando la FIAT fu grande, questo quartiere ne fu in tutte le espressioni della vita sociale un’estensione grandiosa; ora che STELLANTIS langue, il quartiere non è ancora riuscito a trovare una nuova strada dignitosa.
È difficile oggi partecipare a un’iniziativa relativa alla stesura di un nuovo PRG cittadino senza avere prospettive di un futuro ricco di fattori di crescita e stabilità, specie di crescita delle occasioni di lavoro, in una città che sta piuttosto sperimentando erosione per lo spopolamento. Le statistiche ecclesiali davano nel 2017 la parrocchia Gesù Redentore a 14.000 abitanti; ma i dati comunali aggiornati al 31/12/2022 parlavano di una popolazione inferiore agli 11.000. È un problema, perché nell’approfittare di una positiva iniziativa come quella di oggi rischiamo di svelare che l’incertezza sul futuro ha diminuito anche il potere della nostra immaginazione, che fa fatica a sognare in grande, in quanto il realismo è in questo caso una posizione davvero intelligente.
Il territorio del quartiere Mirafiori Nord si colloca nella zona ovest della città; confina col comune di Grugliasco con una zona misto abitativa, industriale, rurale. È delimitato a nord da Via Tirreno; a est da Corso Siracusa, Corso Cosenza e Corso Unione Sovietica; a sud da Corso Tazzoli, Corso Orbassano e Strada del Portone. Dove siamo oggi è il limite meridionale. Sappiamo della varietà degli agglomerati urbani interni al quartiere: si va dalle case operaie e ora case popolari concentrate per lo più in via Giacomo Dina e a sud di via Nallino, alle zone più borghesi di Città Giardino; dalla zona densamente popolata di Santa Rita fino al Centro Europa. A Mirafiori Nord non esiste un vero centro di attrazione, un punto focale principale. Il quartiere sorse nella logica di dover soprattutto garantire abitazioni, per cui il suo vero centro di attrazione fu ed è quello che oggi è il nostro convitato di pietra: la fabbrica. Negli ultimi anni, un ruolo importante, specie nella parte più bassa del quartiere, se lo è ritagliato l’esperienza della Cascina Roccafranca, vero catalizzatore di risorse personali e sostenitore delle energie dal basso. La popolazione è variegata anche dal punto di vista della provenienza. Si può dire che in questa zona di Torino si sono sperimentate tutte le ondate di migrazione interna ed esterna dall’inizio del Novecento: dal Piemonte, dal Veneto, dal Sud Italia, dal nord Africa, dall’est Europa, dal centro Africa, da altre zone, specie dall’America Latina. Attualmente esso è un quartiere multietnico e multiculturale, dove la convivenza si è abituata a far i conti con il diverso e vive di una sorta di lasciar vivere tutti, senza significative tensioni se non verso gli occupanti dell’ex campo ROM di corso Tazzoli, dopo lo smantellamento un po’ sparsi ovunque, con la loro refrattarietà a vere forme di integrazione, col loro modello sociale più incline a stare ai margini e saper sfruttare le debolezze e l’opulenza dei contesti in cui si trovano.
Da mettere in luce è la continua, ciclica presenza di movimenti di partecipazione dal basso. Nel tempo, molte persone hanno avuto un approccio partecipativo alle dinamiche del quartiere in cui vivono. Hanno assunto il dovere di adoperarsi a migliorarlo, a spendersi per esso, capendo la necessità di non dover sempre solo aspettare le istituzioni dall’alto, ma di doverci mettere del proprio, del dover fare la propria parte. È stato così in passato, al tempo dei comitati di quartiere; lo è stato quando si coltivava la coscienza sociale collettiva tramite il Q12; lo è stato per la nascita di Cascina Roccafranca e la fase di Urban 2; lo vuole essere ancora oggi tramite il progetto “Per abitare Mirafiori” che verrà presentato al termine di questa passeggiata di quartiere. Si tratta di un’ottima risorsa per la gestione del quartiere, per il dialogo da favorire da parte delle istituzioni.
Non ci possiamo nascondere alcune difficoltà di questa fase, frutto di fenomeni sociali naturali e di scelte politiche e urbanistiche superficiali e frettolose.
L’invecchiamento della popolazione. Quella del quartiere non ha ancora raggiunto un buon equilibrio tra giovani, adulti e anziani. Tanti anziani vivono legittimamente nelle nostre case dopo aver speso una vita tra queste strade, nei negozi, nelle attività, ma hanno naturalmente costretto i giovani a cercare l’abitazione per lo più altrove. Così, là dove c’erano stuoli di studenti delle elementari e medie, oggi si fatica a tenere aperto una scuola come la “Giovanni Vidari” per i numeri ridotti di bambini.
La concentrazione di soggetti con problemi sociali. Un problema è rappresentato dalla scelta di sfruttare l’edilizia popolare per soddisfare le esigenze di abitazione di tanti indigenti: il risultato è stato quello di aver concentrato in poche vie una popolazione che spesso manca degli strumenti umani, intellettuali, culturali, economici, per provare a riorganizzare la propria vita. E la spirale dei problemi rischia di accentuarsi, tanto più che paradossalmente i servizi sociali sono proprio lontani da questi centri di bisogno.
L’allontanamento degli insediamenti delle istituzioni. La revisione degli apparati amministrativi ha avuto come risultato un allontanamento delle istituzioni dai luoghi dei problemi. Anche la presenza ecclesiale vive la sua stagione critica di presenza: si sa che la Chiesa Cattolica, dopo aver vissuto l’epoca della plantatio nelle periferie, oggi vive una stagione di contrazione, e altre esperienze religiose organizzate non sembrano guardare ai problemi sociali come luogo in cui portare influssi positivi e virtuosi.
Ma l’attaccamento al proprio quartiere è un fattore molto presente, che continua ad attendere con fiducia situazioni di ripartenza. Una domanda che allora si pone è come un ragionamento sul Piano Regolatore Generale possa agganciarsi piuttosto a un esercizio di rigenerazione del quartiere. Ci chiediamo se è possibile partire da questa occasione nata da una riflessione su fattori macro e prendere invece in seria considerazione interventi minori non meno impattanti sul vivere quotidiano. Proviamo a elencarne alcuni.
Guardiamo le diverse aree verdi pubbliche e immaginiamo orti urbani curati dai cittadini, con il loro carico di attività positiva per le persone e di comune impegno nella cura del decoro degli spazi. Immaginiamo la presenza di spazi che possano ospitare attività legate al tempo libero, dove giovani e meno giovani possano ritrovarsi senza dover per forza andare altrove a cercare locali, palestre, spazi di intrattenimento culturale: anche favorendo investimenti del privato.
Riteniamo assolutamente opportuno un intervento sulle case popolari così da permetterne una migliore abitabilità, con l’inserimento di ascensori a fianco delle scale, come venne fatto in alcuni edifici di via G. Dina, così da permettere a tanti anziani o persone in difficoltà di portarsi più facilmente al piano dell’incontro con gli altri.
Speriamo che le varie strutture pubbliche possano essere gestite in modo meno rigido dai regolamenti comunali che ne fissavano i limiti di utilizzo a logiche sorpassate.
Auspichiamo interventi atti a costruire incontro e alleanze con i Rom, per uscire dalla logica del sospetto e del ricorso alla forza pubblica. Chiediamo che la questione dell’invecchiamento della popolazione venga affrontato non tanto con l’insediamento di nuove RSA, ma rigenerando spazi per i bisogni relazionali, intellettuali, materiali degli anziani.
Chiediamo che nelle nostre strade non venga risolto il problema della lontananza dei negozi con il concedere licenze a esercizi che marciano sul disagio o favoriscono i comportamenti deviati, come nel caso di certe tipologie di mini-market verso cui l’amministrazione conosce da tempo il disappunto dei cittadini.
Crediamo che si potrebbe pensare a una maggior interazione tra pubblico e privato nell’affrontare i problemi. Non ci pare di vedere l’ente pubblico, e forse nemmeno una parte dell’opinione generale, così aperti a ragionare su una buona applicazione del principio di sussidiarietà.
Due questioni macro: una diversa sistemazione dell’incrocio di piazza Cattaneo e la questione degli spazi ex FIAT. Lasciando stare la questione del rilancio della produttività di Stellantis, che ne è e che ne sarà degli spazi dell’insediamento industriale a Mirafiori? Si prova a pensare a rendere le zone morte interne, aree a maggior favore della collettività?
Grazie per l’occasione di oggi che ancora una volta ha favorito scambio tra persone di buona volontà. Grazie a nome di tanti cittadini!
Il parroco di Gesù Redentore, don Alberto Savoldi
Torino, 14 novembre 2024″









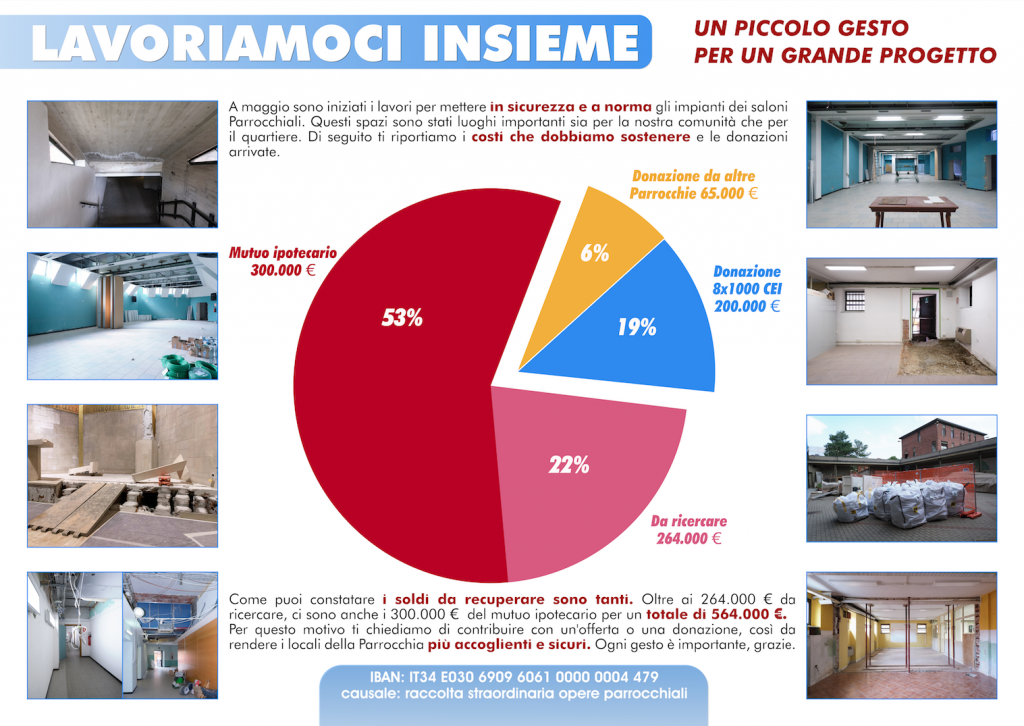
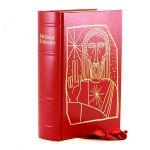
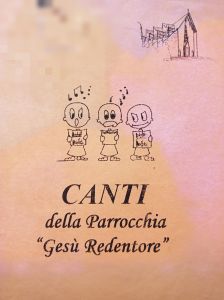 I CANTI DEL RED
I CANTI DEL RED









